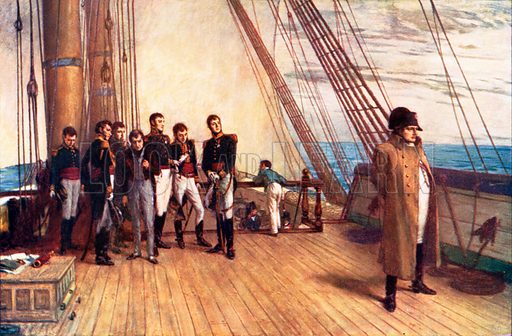Napoleone e lo zucchero
Fino al Settecento inoltrato, rappresentava una costosissima merce d’importazione per l’Europa, proveniente dalle piantagioni intensive delle Americhe (Caraibi e Brasile in pole position). Era lì che le grandi Potenze, Francia e Inghilterra, avevano stabilito i centri della loro produzione, su scala industriale. Mano d’opera a costo zero e guadagni oltre che elevati, anche immediati, spiegavano l’esuberanza del prodotto. Eppure i prezzi restavano alti. Si trattava di un bene rivolto per lo più alle esigenze delle classi agiate e l’offerta non riusciva ad incontrare la domanda dei ceti più umili.

Fin qui, assai più banalmente di quel che possa supporre, la storia dello zucchero.
Fu, poi, niente di meno che Napoleone Bonaparte, più di due secoli fa, ad operare una vera e propria rivoluzione commerciale ed economica, modificando – letteralmente – la vita culinaria di un intero continente. Zucchero, insomma, derivato dalla Bietola, anziché dalla assai più rinomata Canna (Saccharum officinarum).
In realtà e a ben guardare, già nel XVI-XVII secolo un agronomo francese, Olivier de Serres, era arrivato alla medesima conclusione ma la constatazione rimase fine a se stessa, per ancora altri duecento anni.
Le cose cambiarono, nel bel mezzo del XVIII secolo.

Nel dettaglio, correva l’anno di grazia 1747, quando un chimico dell’Accademia delle Scienze di Berlino, un tale di nome Andreas Sigismund Marggraf, si rese conto che il saccarosio era, per entrambe le piante, evidentemente equivalente. Tuttavia, il procedimento adoperato dallo scienziato per l’estrazione andava bene per la fase di laboratorio e non certo per numeri da industria. Fu, dunque, un suo allievo, Franz Karl Achard, a perfezionare il processo.
Nel 1801, Achard aprì uno stabilimento in quel di Kunern, in Slesia, dove produceva il suo sale bianco. Un investimento, tuttavia, tutt’altro che remunerativo. Almeno in prima battuta.
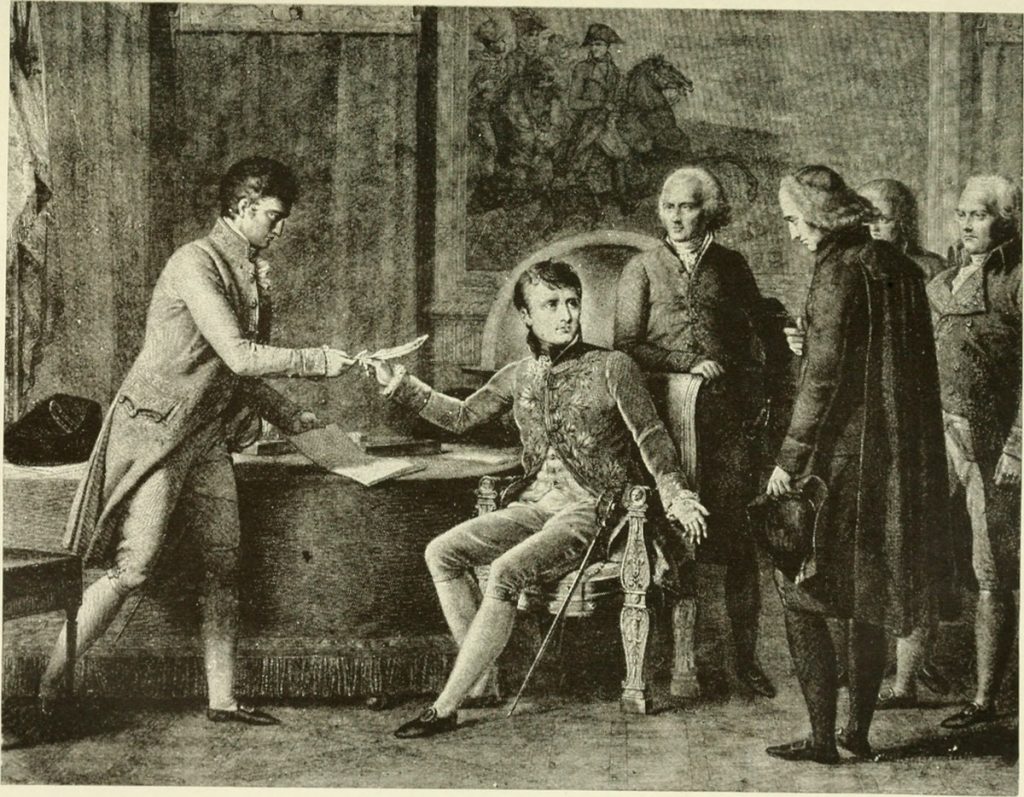
Ed è qui che entrò in ballo proprio l’Imperatore francese. Il generale corso ebbe il merito di trovare una risposta efficace alla pressante richiesta, proveniente dai salottini di Parigi. Quando il 21 novembre 1806 entrò in vigore il decreto di Berlino, scattò quello che in storiografia è comunemente noto come Blocco Continentale. Il divieto, cioè, rivolto a tutte le navi britanniche di gettare l’ancora nei porti sotto l’egida dell’Impero francese.
Il blocco ridefinì totalmente la portata e l’entità del mercato continentale europeo; così, la crisi fece accendere la lampadina al grande stratega, il quale venne a conoscenza dell’esistenza di un piccolo ma innovativo zuccherificio, in Slesia. ‘Perché non replicarlo su larga scala?‘, si chiese.
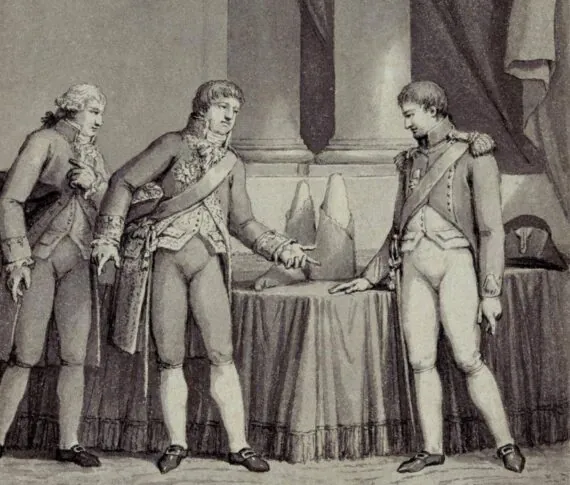
Il Governo finanziò e incentivò – quindi – l’iniziativa, avvalendosi del coadiuvo di un fine botanico, tale Benjamin Delessert, che provvide a perfezionare il metodo Achard. In particolare, l’uomo riuscì ad implementare la resa del vegetale. Eliminò di fatto l’etichetta di coltura di ripiego e, nel 1811, la Francia attuò la conversione di 32.000 ettari di terreno alla coltivazione di barbabietole. Nacquero, su territorio, oltre 40 zuccherifici.
Nel giro di pochi anni, insomma, la Francia e altre parti d’Europa iniziarono a produrre zucchero, senza più dipendere dalle colonie tropicali.
LEGGI ANCHE: Lo Yacon e la profezia di un mondo Sugar free
LEGGI LE ALTRE NEWS CHE TI PARLANO DI MANGIARE SANO