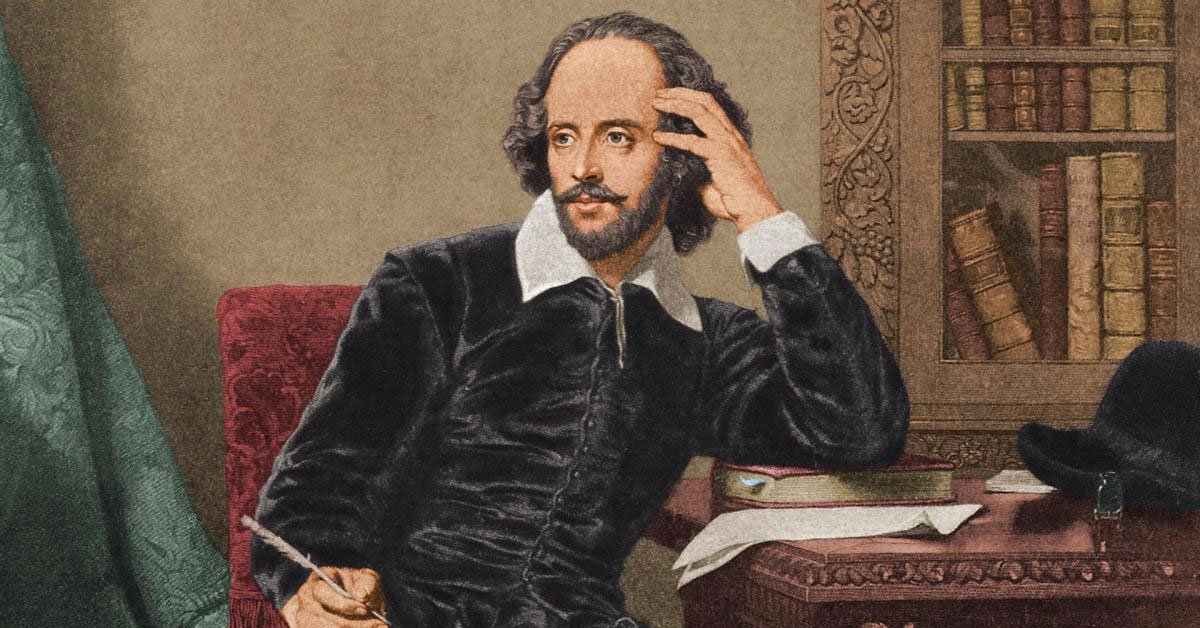Ladyboy: ci vuol coraggio a chiamarli ragazzi
Mai sentito parlare di Ladyboy? Bakla o bayot, nelle Filippine; Waria in Indonesia; Hijra in India; Newhalf, in Giappone. Il termine deriva – più in generale – dalla traduzione di Kathoey, parola che, in thailandese, si utilizza per indicare le donne transgender.

Tranny e shemale arrecano, invece, un’accezione dispregiativa.
PARTIAMO DALL’INZIO
Per tracciarne le origini, bisogna guardare indietro, fino ai tempi della Guerra in Vietnam. Fu allora che, per distrarsi dalla durezza e dalla crudeltà di quanto accadeva, i soldati americani presero a consolarsi, per mezzo di alcol e sesso e per le Kathoey si aprirono le porte… di un nuovo universo. Assai apprezzate, nacque, per loro, l’esigenza di un nome anglofono; un’appellativo, con cui poterle subito indicare.
In quella che è definita, da molti, la Patria del sorriso, del resto, le figure in questione esistevano, da un tempo infinito. Un Paese – quello in analisi – culturalmente aperto, che ha inteso integrarle nel proprio tessuto sociale e culturale, al punto da farne, nel corso della storia, le più celebri amanti o compagne dei regnanti.
Facile, anzi naturale, per un posto in cui la religione – quella buddhista – insegna, tra i numerosi principi, ad accettare la diversità o, comunque, ciò che non rientra nel concetto di binario. Lo Stato, insomma, in cui tutto – o quasi – leggenda vuole, è possibile. Non esiste alcuna forma discriminatoria; pertanto, chi decide di lavorare nel campo dell’erotismo a pagamento lo fa per scelta, non certo per necessità.

Poi, ci sono loro, vale a dire le ladyboy, che sperano di impegnarsi in una relazione seria e duratura. Ebbene, a tal proposito, queste ultime ritengono che i Farang, ovvero gli stranieri, siano assai più interessanti.
E nel resto dell’Asia? Come ci si comporta, al riguardo?
Nelle Filippine, di tradizione cattolica, sussistono, in ogni caso, grande rispetto e accettazione nei confronti della comunità LGBT; dunque, anche verso la categoria, nello specifico. Chi vi appartiene, si muove, perfettamente inserito/a nei diversi ambiti della società. Avere uno o più figli transgender in famiglia, in sintesi, non è oltraggioso. Stesso dicasi, per quel che concerne Indonesia, India e Giappone.
QUESTIONE DI SGUARDI
Dal fisico minuto e dai lineamenti decisamente femminili, sembra difficile riconoscerle: la pelle del volto è liscissima e scevra da imperfezioni. Eppure, se il percorso di transizione non è ultimato, un’osservazione più attenta conduce ad individuare, nell’ordine, il pomo d’Adamo; la voce profonda; l’altezza, superiore alla media, così come la grandezza di mani, piedi e gomiti. Una femminilità, poi, volutamente eccessiva, sbandierata nel trucco, nell’abbigliamento, nella gestualità.

Sorta di chimera per i turisti curiosi di esperienze inedite, rappresentano il lasciapassare per le coppie, ad esempio, desiderose di provare emozioni altre. Le cercano – non il contrario – per una notte d’amore, nei quartieri a luci rosse o nei locali gay, in cui sperano di incontrarne almeno una.
Stereotipo vuole che siano esclusivamente gay. Fatto sta che etero, bisessuali, fluide – secondo la dicitura più comune – sono, soprattutto, creature libere. Connotazione neutra, la loro, immotivatamente e convenientemente adoperata dall’Occidente, per farne qualcosa che, invece, rappresentasse altrimenti. Ed ecco appellarle, nel parlare comune, di una significazione, in fondo, dispregiativa. Qualcosa, di cui non dare traccia. Attributo, sfruttato financo dal mondo del porno, a cui è convenuto e tuttora conviene sfruttare l’opinione di parla ma poco conosce; ragiona, ma solo per sentito dire.
LEGGI ANCHE: Thailandia: visitiamola sì, ma rammentiamo di essere ospiti
LEGGI ANCHE: L’evoluzione della maternità. Adesso è transgender